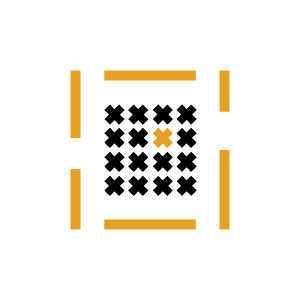24 Settembre 1991 (in ricordo del mio primo e ultimo motorino).
– Perché il mondo è cattivo papà? – chiesi subito dopo che mi avevano rubato il motorino.
– Il mondo non è cattivo. E’ solo lontano. – rispose senza guardarmi. Era lampante che stava pensando ad altro.
– Lontano da che? – dissi nervosamente trattenendo a stento le lacrime.
– Lontano. Man mano che si diventa grandi il mondo si avvicina, lo vedi meglio. E allora dopo vedrai… – si rimise a pensare, a pensare forte. A giudicare dalle rughe d’espressione sulla fronte anche lui aveva avuto qualcosa da ridire con il mondo quel giorno. Anzi, se devo dirla tutta, credo che da quel giorno non abbia più smesso di azzuffarcisi con il mondo.
Tornando al motorino invece, poco rimane da dire se non che iniziai a pedalare. Quella sottrazione mutò il mio senso di mobilità. La bicicletta, da quel momento, allungò le distanze ed ingigantì il mio senso del sacrificio, sia fisico che mentale.
Visto che il mondo era lontano come diceva papà, iniziai a pedalargli incontro.
I due fratelli che mi fotterono il motorino invece, dopo un po’ finirono la miscela e si fermarono al Bar ACI, quello aperto ventiquattr’ore al giorno, quello in cui la disperazione di tanti chiedeva asilo politico dentro la completezza di un negroni alle quattro del mattino o dentro alla scollatura della cassiera ucraina.
Mi pare facessero Russini di cognome. Lorenzo e Stefano. Un anno e nove mesi di distanza tra un cordone ombelicale e l’altro. Dipendenza da girelle in principio. Poi ci fu l’exploit.
Per qualche anno furono famosi. Scippi e furtarelli. Buchi a pranzo e cena.
Ora dimenticati in qualche comunità. Forse reinseriti in città lontane. Comunque sia, andati, kaput.
Quella sera fecero una telefonata da una cabina circostante. Attesero seduti davanti al bar ACI. Sul marciapiedi. Riconobbero quel magrebino da distanza siderale. Aveva un incedere dinoccolato e furtivo all’istesso. Occhi vispi, puntati come periscopi ai quattro punti cardinali.
Iniziarono una comunicazione senza parole, senza gesti, solo sguardi. Come uno scambio di prigionieri alla frontiera. Il magrebino si allontanò con il mio motorino, portandolo a spinta, lungo i binari del treno, per scomparire dopo pochi metri nei pressi di Fettuccia. Uno dei due fratelli si ritrovò una pallina di carta stagnola in tasca. Transazione eseguita.
Come sempre, si avviarono tra l’oscurità complice del Parco Rosselli. Si nascosero dietro un cespuglio di pitosforo. Lì, seduti tra quel profumo, erano comodamente al sicuro. Potevano facilmente tirare su le maniche. Solo le cocciniglie sulle foglie sempreverdi della siepe avrebbero visto i cento buchi sui loro avambracci.
Apparecchiarono a terra sopra aghi di pino secchi. La solita cintura. Il cucchiaino annerito. Un paio di spade. L’improbabile limone è il rumore sordo, da rivoluzione industriale, del treno a caldo dell’acciaieria, addolcito dal lento fluire del fiume Serra poco distante.
Seduti. Schiena contro schiena, da bravi fratelli, perché gli piaceva sostenersi l’un l’altro ma non guardarsi negli occhi nel mentre. Avrebbero ricordato la matrice della loro devianza. Quel padre violento e alcolizzato. Quella madre, donnina di un metro e cinquantaquattro, terrorizzata e intenta a capare fagiolini nell’angolo della cucina di quel mezzanino di via Andrea Costa. Quei lividi temporanei lasciati lì a cuor leggero, come un tatuaggio all’henné. La paura invece no, quella era indelebile.
Era tutto pronto da un po’. Stefano, il più grande, con la mano sinistra occupata dalla spada, strinse la cinta attorno al bicipite del braccio destro con l’ausilio dei denti. Non si aiutavano mai. Gli piaceva mantenere una sorta di dignitosa autosufficienza durante quei riti.
Lorenzo, invece, si era già sparato il suo mezzo grammo di disperazione. I suoi legami associativi erano già di una leggiadra lentezza e avevano acquisito un chiaro senso illogico. Si mise a pensare a Monica. L’euforia temporanea gli fece inventare un amore e cominciò a parlare di tramonti. Ma Monica aveva sposato un dentista e si era trasferita a Perugia. Se ne rese conto piano. Senza fretta.
– Stefano dimmi, perché il mondo è cattivo? – disse Lorenzo, in modo vagamente lamentoso, mentre si grattava via dal viso la sensazione di essere trafitto da centocinquantamila spilli.
– Il mondo non è cattivo, Lorenzo. E’ solo lontano. – sussurrò Stefano tirando con il pollice lo stantuffo verso l’alto, richiamando il rosso del sangue dentro alla siringa, come una medusa da barriera corallina.
– E non ci si incula di pezza Lorenzo se rimaniamo qui, fermi, con questa merda attaccata al braccio.- questa volta sembrò quasi alzare la voce.
Poi il pollice si appoggiò nervosamente sullo stantuffo che iniziò la discesa. Stefano tirò indietro la testa, alzò gli occhi al cielo e vide gli occhi verdi di Maria Rita. Sputò in aria. La saliva gli ricadde sulla guancia.
Quel mezzo grammo conosceva ormai la strada. Quella frase, quella presa di coscienza, iniziò a liquefarsi insieme alle promesse di sempre. Promesse di smettere, di uscire fuori dal giro, di ritirarsi in campagna a crescere un sogno e un bambino.
Piano piano, tra un buco e un altro, Monica, Maria Rita e quel poco di buono che portavano, non tornarono più.
Rimasero sogni.
Rimasero soli.
Erano fottuti.
Come il motorino.
di Juri Cambarau